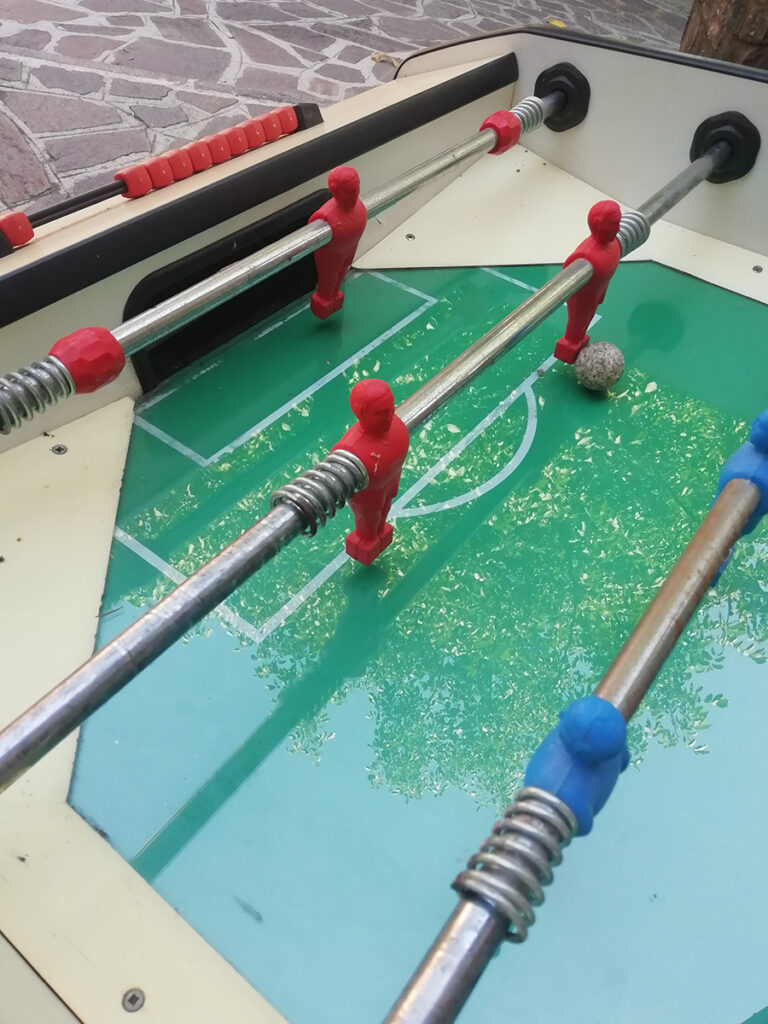Ammissione di una particolare forma di debolezza
Io ho un rapporto complesso con i soldi, soprattutto con i soldi che derivano dal mestiere di scrittore. È necessario iniziare questo pezzo con questa ammissione, che nasconde un disagio, che sto in qualche modo cercando di analizzare in questi ultimi mesi.
L’anno scorso dovevo fare un corso di scrittura presso una scuola superiore. Il corso doveva tenersi tra marzo e giugno del 2020, il lockdown ci sorprese dopo il primo incontro. Decidemmo con i professori che sarebbe stato meglio non sovraccaricare i ragazzi con un ulteriore impegno on line, pensando di poterci rivedere con il nuovo anno scolastico. Purtroppo neanche questo anno scolastico ha consentito la possibilità di un corso in presenza e così abbiamo deciso di fare i nostri 6 incontri via telematica, il mercoledì sera dalle 18 alle 20. Il corso si è concluso ed è stato molto bello lavorare con loro. Pochi giorni fa sono stato contattato dall’associazione organizzatrice per parlare del mio compenso.
Durante quella telefonata è accaduto qualcosa nella mia testa, che ora cerco di riportare sulla pagina. Nelle settimane precedenti avevo appena terminato di leggere un saggio, che mi interrogava sul mio mestiere di autore, di insegnante, ma anche, direi soprattutto, sul mio ruolo di scrittore. Il libro si intitola Economia dell’imperduto di Anne Carson, edito da Utopia e tradotto da Patrizio Ceccagnoli. Nei pochi secondi tra la domanda del responsabile dell’associazione e la mia risposta, mi sono tornate in mente alcune parole della Carson
Forse i poeti sono coloro che sperperano ciò che i loro padri avrebbero risparmiato. Ma il problema rimane: cosa, esattamente, va perduto quando le nostre parole sono sprecate? E dove si trova l’umano dove tali beni si accumulano?
Alla domanda diretta dell’organizzatore: “A quanto ammonta il suo compenso?”. Io avrei dovuto rispondere proprio con le esatte parole della poetessa americana, perché la domanda su quanto dovevo essere pagato non verteva tanto sui soldi, quanto sul rapporto tra sperpero e resto, ovvero ragionavo su cosa resta, su cosa rimane non perduto o, come genialmente tradotto da Ceccagnoli, “imperduto” nell’ambito del lavoro letterario. Cosa era/è restato dei miei incontri con i ragazzi? Quanto di ciò che avevo insegnato loro non era andato sperperato? Come posso quantificare in che modo ciò che io ho dato loro?
È difficile produrre una misurazione concreta di un concetto così immateriale, perché lo stesso interrogarmi e il pormi queste domande poneva il corso fuori dal rapporto insegnante alunno per un serie di punti: a) non avevamo programmi, obblighi e impegni burocratici: quello che avevo davanti a me era una situazione complessa, che non era risolvibile con la semplice cessione dei miei diritti d’autore; b) non avevo ceduto nulla; c) non avevo scritto nulla; io avevo detto loro delle cose, legate al mio saper scrivere delle storie, e loro le avevano ascoltate; d) non c’era nessun fine prestabilito, come spesso accade nei corsi di scrittura, né la produzione di un testo a fine ciclo [d.1], né la partecipazione a un concorso [d.2], né la pubblicazione del racconto [d.3].
Concettualmente avevo prodotto uno sperpero: 6 incontri 2 ore a incontro, 12 ore in cui io avevo parlato e loro avevano ascoltato, in cui loro avevano domandato e io avevo risposto, ma di concreto? Di misurabile, di economicamente rilevante? Nulla.
Ecco perché decisi che il corso era a costo zero, perché io non avevo erogato nessun tipo di servizio all’associazione, ma avevo parlato e discusso e avuto a che fare con 14 ragazzi delle superiori, che avevano dato il loro tempo a me per seguirmi e io avevo dato il mio tempo a loro per farmi seguire.
La mia decisione ha messo in difficoltà l’associazione; una difficoltà, credo, strettamente contabile. L’associazione aveva messo bilancio un corso, un certo tipo di esborso, avevano adempimenti etc. etc., insomma, la mia deliberazione poneva un problema, perché produceva una scelta anti-economica: per me il discorso era semplice, volevo che fosse un atto di gratuità, qualcosa che negasse che lo scambio avuto fosse in qualche modo una transazione. Non ho però pensato attentamente che l’economia è appunto un modo e un sistema che gestisce le relazioni.
Pochi giorni fa, e da questo nascono queste righe, ho ricevuto dall’associazione un attestato, in cui mi si diceva che tutti i ragazzi erano contenti, che avevano apprezzato il mio insegnamento, e inoltre venivo ringraziato per la scelta di farlo a costo zero, vista la particolare temperie storica.
Mi sono chiesto perché un attestato su carta ufficiale? Non bastava una mail di ringraziamento? Poi ho pensato che una comunicazione ufficiale può essere protocollata, e quindi ho compreso che quell’attestato era la mia paga. Senza entrare e citare i saggi e le riflessioni sull’economia e sul dono, basta aver letto il Saggio sul dono di Maus per comprendere come anche il dono ha un suo sistema economico che è solo un altro modo di abitare il mondo, un altro modo di dare e ricevere e costruire rapporti di potere e di bisogno. Verrebbe da dire che non esiste un gesto completamente gratuito, ogni gesto produce una sorta reciprocità economica, che non riusciamo a districare. Sono stato pagato comunque, la mia paga è un attestato che ha quantificato la gratitudine degli alunni e dell’associazione.
Tentativo di passare dal particolare al generale
Sono consapevole di girare attorno a un problema, invece di formularlo chiaramente. Proviamoci, quindi: che fine ha fatto la gratuità? Che fine ha fatto il fare una cosa come gesto senza che questo entri per forza in un rapporto di forza economica in relazione con gli altri? Fare questo discorso è, ne sono consapevole, molto pericoloso, perché – soprattutto nel lavoro culturale – il problema principale è farsi pagare e farsi riconoscere di diritto quello che spetta per l’attività svolta.
Hai scritto un articolo? Devi essere pagato. Hai tenuto un corso di scrittura, di Autocad, di dizione, di lettura a voce alta, di canto? Devi essere pagato. Ti chiedono una traduzione? Devi essere pagato. Io sono d’accordo su questo principio. La mia situazione è, però, diversa, e forse da questo mio punto di vista la mia idea di “economia dell’imperduto” è differente per due ordini di ragioni, se mi passate l’aggettivo, pecuniarie:
- ho già un lavoro per cui vengo pagato
- se ciò che guadagno dai proventi dei miei libri, delle mie lezioni e dei miei articoli fosse la mia unica fonte di reddito, esso mi condannerebbe all’indigenza, ovvero non potrei avere neppure quei 465€ al mese che è il reddito minimo per ottenere un permesso di soggiorno se fossi un cittadino straniero.
Le mie entrate derivano da altro e quindi mi chiedo – in questa situazione particolare – come devo gestire lo sperpero, il di più che faccio; mi domando se sia necessario farmi pagare, se forse non sia in alcuni casi più importante la rottura del patto economico, il mettersi fuori da una matrice di scambio – simbolico o meno – di moneta.
Insomma i soldi che guadagno dal mio lavoro di “scrittore” sono sostanzialmente un di più per la mia vita, e quindi mi chiedo eticamente se chiederli e in che occasione e in che quantità; se non abbia più senso costruire dei rapporti legati alla gratuità, e quindi alla gratitudine, e non dei rapporti costruiti sulla moneta e quindi sullo scambio. Mi interrogo, ma non ho una risposta chiara rispetto a questo mio dubbio: mi rendo conto, però, che tale domanda in fondo sottintende qualcosa che è centrale nella riflessione che facciamo in Quel che resta. Come si può abitare il mondo? Quali sono le pratiche migliori per stare con gli altri? Non è forse necessario un nuovo modo di intendere le relazioni e i rapporti? Di quali gesti “seme” abbiamo bisogno per produrre qualcosa di veramente alternativo a ciò che viviamo tutti giorni? Come si scardina questo nostro modo di esistere e di vivere?
Intermezzo, fingendo una pausa in forma di riflessione critico letteraria, ma serve per capire cosa voglio dire
Nelle sue lettere, appena pubblicate da Il Saggiatore (a cura di Alice Farina, insieme a Giulia De Florio e Elena Freda Piredda), Dostoevskij più di una volta porta sulla pagina il bisogno/mancanza/ricerca di soldi. Nelle mille e più pagine dell’opera ci sono lunghi ragionamenti su come sia meglio organizzare la pubblicazione dei suoi romanzi per vendere le proprie opere, per ricavarne più diritti, in modo da guadagnare di più. L’ossessione del denaro in Dostoevskij può ricondursi alla medesima tensione dei suoi personaggi nel trovare il loro posto nel mondo, ovvero trovare il luogo in cui essi abitano e vivono.
Memorie del sottosuolo, Delitto e Castigo, L’Idiota, i Demoni sono libri, dove è centrale la visione economica del mondo. Il tema, a mio avviso, non è tanto quello legato all’indigenza o alla penuria di denaro quanto alla visione del mondo: il punto di vista di Dostoevskij e dei suoi personaggi è economico, perché si interroga incessantemente su quale sia il modo abitare il mondo, ovvero in quale modo sia possibile esistere su questa terra. La densità del pensiero dostoevskiano sta proprio nel prendere questioni legate ai soldi, innervando su di esse questioni religioso/esistenziali.
Prendiamo il caso dei tre fratelli Karamazov; Ivan e Alesa sono in qualche modo uguali nella loro “gestione economica” della loro esistenza: hanno demandato a un momento altro, a un mondo altro, la soluzione e la restituzione del significato di ciò che vivono hic et nunc. Che sia Dio o il Nichilismo, l’investimento è comunque al di fuori del luogo che abitano e nel quale vivono, tra il discorso del restituire il biglietto di Ivan e la predica di Alesa non c’è una sostanziale differenza: entrambi guardano il mondo come l’ombra di qualcosa che prima o poi si chiarirà, come un passaggio verso altro, dove questo altro può essere visto come elemento positivo o negativo, ma comunque èfuori dal vivere comune. Dimitri, invece, ha verso il mondo sensibile un atteggiamento diverso, legato all’abitudine e all’abitazione: ci vive, ci è, e non può che esserci qui, non ha scelto per sé né l’inquietudine del nichilismo né l’angoscia salvifica della fede in Dio, ma ha preso atto che questa terra è tutto ciò che ha e quindi è tutto ciò che è; Dimitri vive in questa porzione di mondo, e si chiede in che modo sia possibile gestirla al meglio: il suo è un pensiero abitante, perché è un pensiero economico.
Conclusione dubitativa, senza una vera risposta
Contrariamente al personaggio dostoevskiano che porta il mio nome, io non sono un bravo economo, non sono quello che i latini direbbero un buon pater familias, ringrazio di non aver case da gestire, affitti, affittuari, ringrazio di non aver lavori autonomi o attività commerciali in cui io debba chiedere o pretendere il giusto compenso per il mio lavoro, perché per come sono fatto io non saprei districarmi. Mio padre mi dice spesso: “Non sono nato per essere padrone, a me basta il mio”. Io credo di aver introiettato questo insegnamento così profondamente da non poterlo modificare: essere padroni è come essere servi, perché in entrambi i casi si dipende, si è legati da un rapporto economico; accontentarsi “del mio” significa avere la possibilità di essere liberi, e decidere di rinunciare a pretendere un pagamento, perché non modifica la propria vita, perché è più importante il segnale dato che i soldi presi. Ho l’impressione, così, di essere più libero.
Io vorrei dire sì a un progetto non perché mi si paga, ma perché io sento di poter dare qualcosa, o che mi può dar qualcosa, voglio non sentire su di me il peso di un qualsiasi legame economico, o idea di profitto, di vendita, di acquisto legato alla mia presunta o alla concreta capacità intellettuale; vorrei che essa, questa mia capacità, fosse non costretta, fosse produttrice di libertà e non di vicoli economici. So che posso fare questo discorso, perché ho un lavoro che mi permette di scrivere queste parole, so, inoltre, quanto tale discorso sia criticabile, e che possa essere visto come una sorta di atto conservativo e reazionario.
È questo, però, il modo in cui vorrei abitare il mondo, per il tempo che lo abiterò.
In questi mesi ho letto La follia di Hölderlin (Einaudi) di Agamben. A colpirmi nel saggio è stata la scelta, attraverso la quale vengono raccontati gli episodi della vita del poeta tedesco. In alcune pagine ci viene raccontato di Hölderlin regalasse le sue poesie ai visitatori che lo andavano a trovare; quasi che in quella sua follia, presunta/reale/mascherata, assistessimo alla possibilità di vedere un poeta libero senza nessun vincolo economico o estetico che fosse. Liberato dalle ubbie che tormentavano ad esempio Dostoevskij, Holderlin scriveva le sue liriche, rinunciando non solo al compenso, alla gloria, ma anche alla sua stessa identità, firmandosi con uno dei suoi tanti pseudonimi. Quasi, però, a ricordarci che la realtà del vincolo economico è tenace e terribile, e forse non può essere spezzata o non così facilmente, Agamben nelle stesse pagine ci mostra e ci documenta le lettere con cui i tutori di Hölderlin chiedono alla famiglia i fondi per “occuparsi” materialmente del poeta: soldi per i pantaloni, per la legna da ardere, per il mangiare.
Questa immagine, tale profonda contrapposizione, è ciò che più mi interroga in questi mesi. In che modo io posso recidere i legami con il mondo? In che modo posso non far decidere all’economia il mio modo di vivere gli altri? Come posso dare al gesto che faccio la gratuità? È questa una scelta eticamente giusta? Non è che la rescissione di ogni legame economico (sia esso monetario e di dono) sia l’anticamera della rottura di ogni legame, lo sprofondare nella solitudine e nella pazzia? Dove è il giusto limite tra abitare e isolarsi?